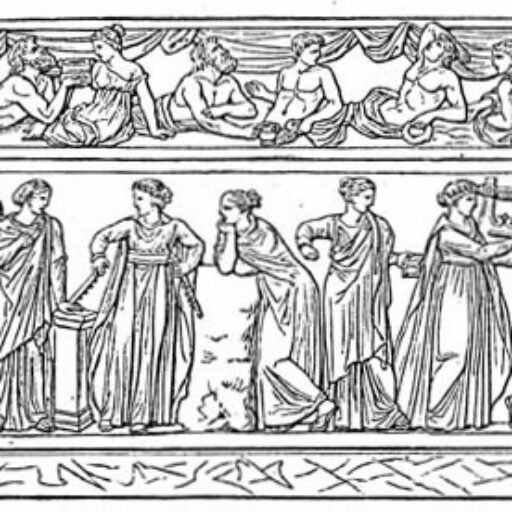Il tempo della nostalgia ritrovata – Appesi alla luna – domenica 9 settembre 2018 – Nel mondo di oggi essere “nostalgici” depone a sfavore del “nostalgico” in quanto considerata attitudine negativa, passiva o pessimistica ed è per lo meno uno svantaggio prossimo alla depressione! La nostalgia, troppo spesso connotata come emozione che porta a volgere lo sguardo all’indietro, a pietrificare e immortalare il passato, può al contrario in verità aiutarci a costruire il futuro. Permettendoci di recuperare emozioni e sentimenti dell’infanzia, ferite che vengono da lontano, momenti di abbandono, odori e colori del passato, la nostalgia attiva la conoscenza emotiva, il rapporto con il senso del tempo e della memoria partecipando così a progettare il futuro. Fare i conti con la nostalgia è quindi indice di un buon rapporto con il proprio passato emotivo e con se stessi. Rossana Maspero, in compagnia di Giorgia Würth, ne parla con Andreas Barella (de La Voce delle Muse) che narrerà di Ulisse e del suo Nostos, della sua voglia di tornare a casa, anche a scapito dell’immortalità offertagli dalla ninfa Calipso. Altri ospiti: Davide Staffiero, scrittore, Massimo Turuani, Presidente della Società Mastri Panettieri Pasticceri confettieri e Carmen Pellegrino, scrittrice e “abbandonologa”. Ascolta la trasmissione.
Il tempo della nostalgia ritrovata – Appesi alla luna – domenica 9 settembre 2018 – Nel mondo di oggi essere “nostalgici” depone a sfavore del “nostalgico” in quanto considerata attitudine negativa, passiva o pessimistica ed è per lo meno uno svantaggio prossimo alla depressione! La nostalgia, troppo spesso connotata come emozione che porta a volgere lo sguardo all’indietro, a pietrificare e immortalare il passato, può al contrario in verità aiutarci a costruire il futuro. Permettendoci di recuperare emozioni e sentimenti dell’infanzia, ferite che vengono da lontano, momenti di abbandono, odori e colori del passato, la nostalgia attiva la conoscenza emotiva, il rapporto con il senso del tempo e della memoria partecipando così a progettare il futuro. Fare i conti con la nostalgia è quindi indice di un buon rapporto con il proprio passato emotivo e con se stessi. Rossana Maspero, in compagnia di Giorgia Würth, ne parla con Andreas Barella (de La Voce delle Muse) che narrerà di Ulisse e del suo Nostos, della sua voglia di tornare a casa, anche a scapito dell’immortalità offertagli dalla ninfa Calipso. Altri ospiti: Davide Staffiero, scrittore, Massimo Turuani, Presidente della Società Mastri Panettieri Pasticceri confettieri e Carmen Pellegrino, scrittrice e “abbandonologa”. Ascolta la trasmissione.
Tag Archives: Ulisse
I grandi miti greci, ogni settimana con il Corriere della Sera

Vi segnaliamo che in edicola, ogni settimana al martedì, assieme al Corriere della Sera, vengono pubblicati degli agili libretti su un personaggio specifico della mitologia greca. Le uscite sono 30 e i protagonisti sono elencati più sotto. La presentazione ufficiale della collana: “Dalle avventure di Eracle alla tragedia di Antigone, dagli enigmi della Sfinge al giudizio di Paride: Corriere della Sera presenta Grandi miti greci, una collana di monografie dedicate agli eroi e agli dèi della mitologia ellenica, appositamente scritte da autorevoli docenti universitari con la curatela di Giulio Guidorizzi. In ogni libro, la ricostruzione del mito, gli autori e le opere che nei secoli se ne sono occupati, una sezione antologica con i testi più rappresentativi e utili apparati critici. Immergiti in un mondo di storie antiche quanto la cultura occidentale, imprese intramontabili e personaggi mitici che da più di due millenni nutrono il nostro immaginario. Le grandi storie sono eterne.”
Noi le stiamo leggendo e vale proprio la pena. In una prima sezione vi è il racconto e l’analisi del mito; in una seconda sezione vi sono gli sviluppi nell’arte del mito trattato: musica, quadri, libri, piéce teatrali ispirate dal mito vengono raccontate e commentate. In una terza sezione vi sono poi degli estratti della storia dalle opere più famose che ne hanno trattato. Una ricca bibliografia e sitografia completa ogni volumetto, che si legge in un paio di ore e lascia l’anima leggera e soddisfatta. Una lettura consigliata. Non è detto che traendo spunto da questa bella iniziativa non ci metteremo in futuro a recensire qualche volume o a fare delle entrate qua sul blog sui vari dèi, dee, eroi. Man mano che lo faremo, potete cliccare sui vari link.
Ogni volume ha un curatore diverso, che indicheremo nei vari post. L’intera collana di trenta volumi è a cura di Giulio Guidorizzi. Guidorizzi è grecista, traduttore, studioso di mitologia classica e antropologia del mondo antico. Ha scritto numerosi libri sulla mitologia. Noi vi consigliamo, per iniziare, il suo bellissimo Il mito greco (in due volumi, usciti nel 2009 e nel 2012).
Il piano dell’opera (ogni volume costa 7,90 Euro e li trovate sul sito del Corriere della Sera). NOVITÀ NOVEMBRE 2021: ATTUALMENTE LA COLLANA È DISPONIBILE SUL SITO DEL CORRIERE, NON SAPPIAMO FINO A QUANDO.
- Edipo – Il gioco del destino
- Dioniso – L’esaltazione dello spirito
- Apollo – La divina bellezza
- Zeus – Le origini del mondo
- Arianna – Le insidie dell’amore
- Orfeo – La nascita della poesia
- Ulisse – Il viaggio della ragione
- I viaggi di Odisseo – Partenza e Polifemo – Parte 1 (di 4)
- I viaggi di Odisseo – Eolo, i Lestrigoni e Circe – Parte 2 (di 4)
- I viaggi di Odisseo – Il Regno di Ade – Parte 3 (di 4)
- I viaggi di Odisseo – Le Sirene, Calipso, i Feaci – Parte 4 (di 4)
- Odisseo torna a Itaca – Parte 1 (di 2)
- Odisseo torna a Itaca – Parte 2 (di 2)
- Telegono, il figlio di Odisseo e della Maga Circe
- Medea – La condizione femminile
- Prometeo – Il dono del fuoco
- Antigone – La ragione di stato
- Fedra – L’insana passione
- Ade e Persefone – Gli dèi degli inferi
- Enea – L’eroe di una nuova dinastia
- Il mito di Enea – Origini e Guerra di Troia – Parte 1 (di 3)
- Il mito di Enea – Fuga da Troia, lungo viaggio per mare, il Lazio – Parte 2 (di 3)
- Il mito di Enea – Riassunto scolastico dell’Eneide – Parte 3 (di 3)
- L’Eneide – Introduzione
- L’Eneide – Il pio Enea
- L’Eneide – Quale versione leggere?
- L’Eneide – Turno, il re guerriero
- L’Eneide – Venere vs. Giunone
- L’Eneide – Son pensieri in libertà
- L’Eneide – Le vittime guerriere
- Circe – La seduzione e la magia
- Eracle – L’eroe più popolare
- Il mito di Eracle (Parte 1 di 11): nascita e giovinezza
- Il mito di Eracle (Parte 2 di 11): prime avventure e la pazzia
- Le dodici fatiche di Eracle: 1) Il leone di Nemea; 2) L’idra di Lerna
- Le dodici fatiche di Eracle: 3) La cerva di Cerinea; 4) Il cinghiale Erimanzio
- Le dodici fatiche di Eracle: 5) Le stalle di Augia; 6) Gli uccelli della palude di Stinfalo
- Le dodici fatiche di Eracle: 7) Il toro di Creta; 8) Le cavalle carnivore di Diomede
- Le dodici fatiche di Eracle: 9) La cintura di Ippolita, regina delle Amazzoni
- Le dodici fatiche di Eracle: 10) Le mandrie di Gerione
- Le dodici fatiche di Eracle: 11) I pomi d’oro delle Esperidi
- Le dodici fatiche di Eracle: 12) La cattura di Cerbero, il guardiano infernale
- Il mito di Eracle (Parte 3 di 11): la morte di Ifito
- Il mito di Eracle (Parte 4 di 11): Onfale la regina della Lidia
- Il mito di Eracle (Parte 5 di 11): Esione, figlia di Laomedonte
- Il mito di Eracle (Parte 6 di 11): la conquista dell’Elide
- Il mito di Eracle (Parte 7 di 11): la conquista di Pilo
- Il mito di Eracle (Parte 8 di 11): i figli di Ippocoonte e la storia di Auge
- Il mito di Eracle (Parte 9 di 11): Deianira
- Il mito di Eracle (Parte 10 di 11): Eracle a Trachine
- Il mito di Eracle (Parte 11 di 11): la morte di Eracle
- La Voce delle Muse ed Eracle
- Andreas Barella sul Mitologia Express vi introduce al mito di Eracle
- Teseo – Lo stato e le donne
- Elena – La bellezza che genera la guerra
- Afrodite – La primavera dell’amore
- Achille – Il guerriero vulnerabile
- Narciso – La morte, lo specchio e l’amore
- Atena – La dea invincibile
- Poseidone – La forza del profondo
- Le Sirene – Incanto e seduzione
- Ettore – L’eroe e la sua sposa
- Artemide – La natura selvaggia
- Giasone – La verità su un eroe
- Agamennone – Il re dei re
- Perseo – L’audacia dell’avventura
- Hermes – Il dio dell’astuzia
- Sisifo – I grandi peccatori
Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse
Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Offrici un caffè
Due saggi maestri: il Centauro Chirone e la Maga Circe
 La Voce delle Muse è spesso attiva nelle scuole con insegnanti e ragazzi (qui tutti i dettagli del nostro lavoro nelle scuole). Andreas Barella, una delle Muse, ha pubblicato qualche anno fa un volume sul lavoro scolastico con la mitologia. Il libro si intitola “Adolescenza, il Giardino Nascosto”. Eccone un estratto dedicato a tutti i docenti che ci leggono! Maggiori dettagli sul libro li trovate sul sito della Casa Editrice Ericlea, dove potete anche ordinare il volume.
La Voce delle Muse è spesso attiva nelle scuole con insegnanti e ragazzi (qui tutti i dettagli del nostro lavoro nelle scuole). Andreas Barella, una delle Muse, ha pubblicato qualche anno fa un volume sul lavoro scolastico con la mitologia. Il libro si intitola “Adolescenza, il Giardino Nascosto”. Eccone un estratto dedicato a tutti i docenti che ci leggono! Maggiori dettagli sul libro li trovate sul sito della Casa Editrice Ericlea, dove potete anche ordinare il volume.
I docenti e il loro ruolo mitologico – Nell’antichità l’educazione dei giovani di famiglia altolocata (ma spesso il mito situa in questa categoria le persone che hanno un valore intrinseco, interiore e psichico, e non solo quelle nate da un alto lignaggio) è affidato a persone di prestigio. Un esempio illustre è l’educazione di Achille. L’eroe della guerra di Troia, abbandonato dalla madre, viene affidato dal padre al centauro Chirone.
Altri personaggi sono altrettanto ricchi, per esempio il ruolo delle sacerdotesse della magia femminile che insegnano i loro segreti alle persone che amano (Medea con Giasone, Arianna con Teseo e soprattutto Circe con Ulisse), oppure i molti insegnamenti divini che gli esseri umani colgono come eccezionali occasioni di crescita.
Il centauro ha la peculiarità di occuparsi a tempo pieno della educazione dei giovani, è la sua attività principale. Per questo motivo Chirone è la prima figura mitologica che vorrei assurgere a simbolo del ruolo di docente all’interno del percorso di crescita degli adolescenti. La figura del centauro ha la ricchezza della ambivalenza di cui abbiamo parlato a lungo nei capitoli precedenti e che contraddistingue il mondo adolescenziale.
Chirone è una figura di natura doppia, a metà strada tra bestia ed essere umano. Il suo corpo è di cavallo, mentre il busto e la testa sono umani. Esso ha un temperamento selvaggio e aggressivo, ma sa dimostrarsi anche benevolo e ospitale. Un po’ come la nostra società dei consumi: sa essere aggressiva, ma sa anche come prendersi cura dei suoi membri. E come l’adolescenza ha questa capacità di essere una cosa e anche il suo esatto contrario. È uno straordinario maestro di caccia (colui che dà la morte) ma anche uno scienziato che conosce a menadito la medicina (colui che dona e mantiene la vita). Si tratta di un essere intermedio tra natura e cultura. È il più saggio e il più sapiente tra tutti i Centauri, ed è immortale. Il suo insegnamento è basato sulla musica, sull’arte della guerra e della caccia, sulla morale e sulla medicina.
Il centauro offre ai giovani a lui affidati ciò che nessun essere umano potrebbe dar loro: trasforma infanzia e adolescenza in un incantesimo silvestre che annulla qualsiasi distanza tra natura e cultura. Non insegna ai suoi allievi le complesse regole della caccia nelle selve, fa di loro, come Achille, dei corridori dei boschi che non si servono di trappole né di armi. Il centauro confonde le categorie e la sua scienza non viene trasmessa attraverso l’insegnamento, egli esercita sui fanciulli a lui affidati un’imposizione dei suoi doni che li trasforma mediante una sorta di modificazione strutturale della loro personalità. La storia del centauro costituisce una versione mitologica dell’iniziazione.
È proprio questo il primo augurio che porgo ai docenti: quello di essere partecipi come il centauro all’insegnamento che donano ai ragazzi. Sono naturalmente cosciente che la vita quotidiana dell’insegnamento è ricca di molti aspetti burocratici e strutturali che hanno la tendenza a soffocare la personalità degli insegnanti, ma perché non arricchire la propria visione di se stessi con queste immagini? Trasmetterli agli allievi, vivere la materia che si insegna e renderla squillante per i giovani è una sfida che dovrebbe sempre capeggiare nella mente e nella programmazione degli insegnanti. Perché è questo compito che rende vivi, nella mia esperienza, i docenti, la materia e gli allievi stessi.
Anche la maga Circe che compare nel Canto X dell’Odissea (e maga sta per sacerdotessa che conosce le arti segrete della natura) è una straordinaria insegnante. Il suo modo di istruire è diverso, almeno all’inizio, da quello di Chirone, in quanto per imparare da lei bisogna riconoscere il suo potere e la sua diversità, senza averne paura. Cosa che i marinai di Ulisse non riescono a fare, e vengono tramutati in porci. Ulisse, con l’aiuto di Ermes, diviene immune alla magia trasformativa di Circe e può, una volta tenutane a bada la pericolosità, impararne i segreti. Di nuovo, come con Chirone, si tratta di insegnamenti che vengono impartiti grazie all’esperienza, al vivere a stretto contatto l’una con l’altro e sono segreti e insegnamenti legati al mondo naturale e istintivo. In questo regno si imparano i segreti che permettono poi di vivere e regnare anche nel mondo della ragione.
È questo il grande segreto che i due prototipi degli insegnanti ci comunicano. Proprio con questa mentalità si può e si deve affrontare il lavoro di docente. La messa in scena rituale che andiamo a presentare nella seconda parte è un esempio di come sia possibile farlo. Lo svolgimento di questo tipo di attività può essere facilmente programmato all’interno delle ore scolastiche che le scuole medie riservano alla conoscenza e allo studio della mitologia. E che le scuole superiori dedicano allo studio della filosofia. Si tratta di un’ottima occasione per rendere naturali e vive le storie che lette nell’antologia scolastica suonano vecchie e noiose. È l’occasione per le docenti e i docenti di diventare un po’ Chirone e un po’ Circe e trasportare gli studenti da un mondo interamente fattuale e nozionistico in un mondo fatato, in un incantesimo che diminuisce le distanze tra mondo mentale, mondo emotivo e mondo fisico, ricreando quella atmosfera silvana e boschiva in cui Circe e Chirone formano i futuri Re, i futuri Eroi e le future Eroine, le future Maghe.
Tratto da: Andreas Barella, Adolescenza, il Giardino Nascosto, Ericlea, 2010. Maggiori dettagli sul libro e possibilità di ordinarlo in formato cartaceo o e-book.
Recensione a “La Figlia di Omero” di Robert Graves
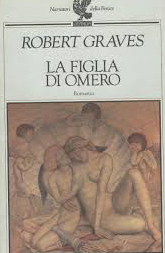 Ne La figlia di Omero Graves parte dalla interessante idea (ripresa da Samuel Butler) che l’Odissea sia stata scritta da Nausicaa figlia del re degli Elimi. Graves ha composto questo libro nel 1955 dopo aver sposato la teoria di Butler che a scrivere l’Odissea sia stata in realtà una donna vissuta nella Sicilia dell’ottavo secolo avanti Cristo. Butler situa lo scenario dell’Odissea proprio in Sicilia, e avanza l’idea che la storia sia stata scritta circa 150 anni dopo che Omero ha composto l’Iliade. Una storia scritta da una donna e pensata per le donne, proprio come l’Iliade è un libro di uomini scritto da un uomo per altri uomini. La principessa Nausicaa è figlia del re Alcino e della Regina Arete e vive nel regno del padre nella Sicilia occidentale, vicino ad Erice. Suo fratello scompare dopo un litigio con la moglie, e il padre parte alla sua ricerca. Nausicaa rimane quindi sola a difendere il regno dal selvaggio gruppo di pretendenti che cercano di conquistare la sua mano e il suo regno. Le avventure e disavventure attraverso le quali deve passare Nausicaa sono chiaramente correlate con quanto Ulisse dovrà vivere nell’Odissea e i parallelismi sono molto divertenti e ben congegnati. Non li svelo per lascarvi il piacere della lettura. Forse un consiglio è di rileggere prima l’Odissea per potersi gustare tutti i rimandi e i divertissment dell’Autore.
Ne La figlia di Omero Graves parte dalla interessante idea (ripresa da Samuel Butler) che l’Odissea sia stata scritta da Nausicaa figlia del re degli Elimi. Graves ha composto questo libro nel 1955 dopo aver sposato la teoria di Butler che a scrivere l’Odissea sia stata in realtà una donna vissuta nella Sicilia dell’ottavo secolo avanti Cristo. Butler situa lo scenario dell’Odissea proprio in Sicilia, e avanza l’idea che la storia sia stata scritta circa 150 anni dopo che Omero ha composto l’Iliade. Una storia scritta da una donna e pensata per le donne, proprio come l’Iliade è un libro di uomini scritto da un uomo per altri uomini. La principessa Nausicaa è figlia del re Alcino e della Regina Arete e vive nel regno del padre nella Sicilia occidentale, vicino ad Erice. Suo fratello scompare dopo un litigio con la moglie, e il padre parte alla sua ricerca. Nausicaa rimane quindi sola a difendere il regno dal selvaggio gruppo di pretendenti che cercano di conquistare la sua mano e il suo regno. Le avventure e disavventure attraverso le quali deve passare Nausicaa sono chiaramente correlate con quanto Ulisse dovrà vivere nell’Odissea e i parallelismi sono molto divertenti e ben congegnati. Non li svelo per lascarvi il piacere della lettura. Forse un consiglio è di rileggere prima l’Odissea per potersi gustare tutti i rimandi e i divertissment dell’Autore.
Graves, Robert. La Figlia di Omero. 1955. Milano: Guanda, 1992. 350 pagine, 16 Euro, fuori catalogo, dovete trovarlo su una bancarella di libri usati.
Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse
Chi è Robert Graves e recensioni ad altri suoi volumi
Poetica di Robert Graves
Recensione a “Il mio nome è Nessuno” di Valerio Massimo Manfredi
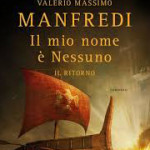 Un’amante della mitologia come me non poteva lasciarsi sfuggire il romanzo “Il mio nome è Nessuno – Il ritorno” di Valerio Massimo Manfredi, uscito per Mondadori un anno dopo la prima parte di questo dittico romanzesco, intitolata “Il mio nome è Nessuno – Il giuramento”. Se nel primo volume Manfredi ripercorre le esperienze di Ulisse a partire dall’infanzia e fino alla fine della guerra di Troia, nel secondo narra invece il viaggio di ritorno del re di Itaca da Troia fino alla sua isola. Viaggio che, come noto, dura dieci anni e contempla numerose e svariate avventure. Non riassumerò la vicenda, ai più nota, ma volevo spendere alcune parole sull’esperimento di Manfredi di rinarrare il mito di Ulisse-Odisseo.
Un’amante della mitologia come me non poteva lasciarsi sfuggire il romanzo “Il mio nome è Nessuno – Il ritorno” di Valerio Massimo Manfredi, uscito per Mondadori un anno dopo la prima parte di questo dittico romanzesco, intitolata “Il mio nome è Nessuno – Il giuramento”. Se nel primo volume Manfredi ripercorre le esperienze di Ulisse a partire dall’infanzia e fino alla fine della guerra di Troia, nel secondo narra invece il viaggio di ritorno del re di Itaca da Troia fino alla sua isola. Viaggio che, come noto, dura dieci anni e contempla numerose e svariate avventure. Non riassumerò la vicenda, ai più nota, ma volevo spendere alcune parole sull’esperimento di Manfredi di rinarrare il mito di Ulisse-Odisseo.
Manfredi fa quello che ogni lettore dell’Odissea (e dell’Iliade) fa nella sua testa e nel suo cuore quando si immerge davvero nei testi di Omero: costella nella sua esperienza personale gli archetipi che le due epiche contengono e fanno danzare nella psiche di chi le ascolta (o legge). Manfredi lo fa nel suo modo personale: come già in altri suoi romanzi, per dare un tocco esotico alle vicende cambia leggermente i nomi dei personaggi (Kirke invece di Circe, Odysseo invece di Odisseo, e così via) e intesse la vicenda di Ulisse con quelle di altri personaggi di suoi romanzi (Diomede, per esempio, o il destino del Palladio). E soprattutto, colma il racconto con quello che possiamo definire l’”inchiostro bianco”, vale a dire quelle parti che il lettore immagina, gli spazi vuoti tra una frase e l’altra, le frasi non dette, i sentimenti non espressi, i dubbi che restano tali nella mente dei personaggi e del lettore. Come è giusto che sia, Manfredi spiega, interpreta, aggiunge pensieri e interpretazioni e dolori espressi dalla voce in prima persona di Ulisse. A volte suggerisce interpretazioni interessanti, e si ha la percezione che l’Ulisse che parla tramite Manfredi, parli la voce del ventunesimo secolo ed esprima dubbi e paure proprie del nostro tempo. Quando questo accade la lettura si fa interessante e ricca di spunti sui quali riflettere. A volte quando invece Manfredi tenta di descrivere dubbi e problemi che immagina dei greci antichi, e lo fa usando un linguaggio che scimmiotta un po’ quello di Omero, ecco che, secondo me, la voce di Manfredi si fa meno interessante. Anche la lunga parte finale, in cui l’Autore descrive l’ultimo viaggio di Ulisse (non quello dantesco descritto nella Divina Commedia!), viaggio profetizzato da Tiresia e in cui Ulisse dovrà andare alla ricerca del perdono da parte di Poseidone, sembra più un’epica da fumetto americano con il protagonista preda di dubbi esistenziali, che un’epopea mitologica.
Se la mitologia adempie al suo scopo, parla ai lettori-ascoltatori di cose importanti per loro, nel momento in cui vengono lette e lasciate danzare nella psiche. Il compito del mito è proprio questo: rimanere vago e interpretabile per continuare a sussurrare quello che la nostra interiorità ha bisogno di sentire e di elaborare. E deve farlo in modo ricco e pieno di significati simbolici assodati e che hanno funzionato per generazioni di esseri umani. Per questo motivo, il libro di Manfredi è parziale e ci racconta UNA versione, UNA visione del ricco mondo omerico. Al lettore giudicare se vale la pena affidarsi all’interpretazione di una persona singola o se affidarsi al ricco e simbolico linguaggio di Omero, e colmare personalmente gli spazi lacunosi della vicenda, soffrendo in modo personale e per motivi diversi quando Ulisse piange ma non spiega perché. Io ho letto volentieri il libro di Manfredi, come se fosse (e lo è) una variante su di un tema conosciuto, che è l’opera di Omero in versione originale. Se però non avete mai letto l’Odissea e pensate di approcciarvi al poema che è alla base della nostra cultura e civiltà, allora il mio suggerimento è quello di cominciare dall’originale. Per esempio nella leggibilissima versione in prosa a cura di Maria Grazia Ciani ed edito da Marsilio. Buona scoperta o riscoperta delle avventure di Ulisse, l’uomo dalla mente colorata.
Andreas
Manfredi, Valerio Massimo. Il mio nome è Nessuno – Il Ritorno. Milano: Mondadori, 2013.
Omero. Odissea. A cura di Maria Grazia Ciani. Venezia: Marsilio, 1994.
Manfredi, Valerio Massimo. Il mio nome è Nessuno – La Promessa. Milano: Mondadori, 2012.